|
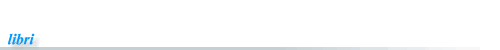
A. Battista Sangineto:
Il senso dei luoghi di Vito Teti, Donzelli Editore, 2004 |
|

| |
Un giorno, uno qualunque, apri un libro
e ti viene incontro un amico che ti prende sottobraccio e ti conduce in
luoghi dove sei già stato, ma che non hai visto oppure in luoghi che non
avevi mai visitato, eppure conoscevi perché di quel paese avevi già visto
tutto: le chiese, le piazze, le rughe, le case, i bambi- ni che giocano
per strada e, persino, i vecchi seduti a prendere il fresco davanti
l’uscio di casa. Cammina, cammina, l’amico ti mostra i monti, le valli, le
fiuma- re, le rovine ed i paesi della Calabria, te ne racconta la vita e,
soprattutto, l’ab- bandono, la morte. Il racconto procede con lo stesso
ritmo delle camminate che si fanno con gli amici: a volte spedito come per
raggiungere una meta, altre lento perché l’amico ti parla, altre volte ci
si ferma perché la conversazione me- rita un approfondimento, altre ancora
si cammina in un silenzio pieno di signi- ficati, empatico, perché colori
e odori ti s’impigliano negli occhi e nel naso. Quell’amico
affabulatore si chiama Vito Teti ed ha scritto il più bel romanzo degli
ultimi anni che s’intitola “Il senso dei luoghi”, pubblicato, nel 2004, da
Donzelli Editore.
Mi piacerebbe molto che s’ingenerasse
l’equivoco, certo dell’approvazione dell’autore, che si tratti di un
romanzo e non di un ponderoso saggio di quasi 600 pagine con altrettante
foto. Il suo è un roman philosophique alla Milan Kun- dera, ma
anche un romanzo sentimentale fitto di storie d’amore poetiche e di
abbandoni strazianti. Un romanzo in cui l’antropologia s’è felicemente
“sciol- ta” in letteratura, un romanzo la cui trama è intessuta delle
storie dei tanti luo- ghi e non-luoghi di cui è caleidoscopicamente
composta la Calabria. Le Cala- brie. Da una storia ne gemma un’altra e poi
un’altra ancora, una storia dalla quale si espandono e si ritraggono
all’infinito infinite storie, come in una recen- te teoria sul respiro
dell’Universo.
La storia dell’eccidio della famiglia dei marchesi Alberti di
Pentedattilo com- piuto dal rivale barone Abenavoli del Franco o quella
del quadro della Madon- na col Bambino di Mileto apparso sulla spiaggia e
che gli abitanti del luogo ri- buttano in mare temendo che l’effigie porti
lutti e tragedie, ma il quadro ritorna a galla finché i militesi non
decidono, di fronte al miracolo, di costruire nel luo- go dell’apparizione
una chiesa in onore della Madonna con il Bambino. La sto- ria, ancora, di
San Teodoro che, uccidendo il drago, libera Cerenzia, dopo aver chiesto a
Dio di fermare il tempo per permettergli di portare a termine l’impre- sa.
C’è anche la storia, vera, dei chiodi infissi nei muri di Ghorìo di Rogudi
ai quali le madri legavano con una corda i bambini, per paura che essi
cadessero negli orridi burroni che delimitano il paese. Il libro, come si
conviene ai roman- zi più riusciti, è popolato da straordinari personaggi
come Mico Pelle (sembra davvero un personaggio inventato, ma non lo è),
l’aedo contadino che canta di natura e di ‘ndrangheta, di fatica inumana e
d’amore, d’occupazione delle terre e d’Ulisse allargando le mani per
cercare di contenervi tutte queste storie e consegnartele in dono, per
ricordo, per memoria. Quella memoria persistente, per esempio, delle
Naradi, streghe cattive delle fiumare che portavano via i bambini nel loro
rovinoso corso e che non sono altro che le Naiadi, dispettose ninfe delle
acque cantate dagli autori antichi greci e latini.
Quell’amico ti riprende sottobraccio e, mentre camminate, ti spiega come
e perché i paesi calabresi percepiscano ed abbiano, tutti, una seconda
vita altro- ve: nel passato (i popoli antichi), nelle Americhe
(l’emigrazione), nell’interno (i paesi abbandonati), lungo le coste (i
doppi dei paesi abbandonati). Altrove. Ti racconta che l’emigrante lascia
in paese una parte del proprio io, la propria om- bra e che il paese
lasciato diventa, per chi è andato via, un’ombra perduta. Ti racconta
della fuga reale e metaforica delle genti di Calabria dai propri paesi,
dalla regione, dalla propria storia, dalla propria memoria. Il romanzo di
Teti è, anche, un potente e tragico affresco che contiene le rovine dei
paesi abbando- nati e la fuga d’intere comunità in dissoluzione. Una
società ed una civiltà in disfacimento, come l’impero austroungarico
descritto da Joseph Roth. Dall’in- treccio d’analisi scientifica e pagine
di letteratura scaturiscono con precisione i dati costitutivi della
mentalità dei calabresi. Dalla lettura di questo libro s’in- tuisce quanto
sia forte in Teti la volontà di non essere distaccato dall’oggetto dei
suoi studi, quanto consapevole sia la scelta di non rinchiudersi nella
torre dello specifico scientifico.
In alcuni casi l’amico ti pare particolarmente ispirato, come quando si
ferma per parlarti delle nuvole, quelle descritte da Alvaro, Fortunato
Seminara e Francesco Perri, quelle nuvole che, veleggiando, alludono
all’esodo di massa dei calabresi e che sono metafore di viaggio e di
spostamento come quelle, sug- gerisce Teti, dei film di Wenders, Coppola e
Ray. Le nuvole sono insieme il la- to nascosto e quello più evidente del
paesaggio. Sono, insieme, inconscio e su- per io dei luoghi. Sei fermo ad
ascoltarlo, rapito ed incredulo, quando ad un tratto lui si gira e ti
mostra una delle immagini più belle che siano state scritte negli ultimi
anni: quella delle statue dei Santi che girano per i vicoli e le strade
dei paesi e che sembrano volare in alto, sopra le nuvole, come le persone
che se ne sono andate. Guardate le fotografie dei Santi portati in
processione e, d’improvviso, capirete anche voi.
Le fotografie di questo volume rappresentano luoghi sospesi e persone dai
tratti imprecisi, come se dovesse essere lo sguardo dello spettatore a dar
loro compiutezza. Le mucche nella chiesa della vecchia Africo, il grigio
abbagliante della fiumara dell’Amendolea, il marinaio ritratto nella sua
casa di Pentadattilo, il fratello di Corrado Alvaro, don Massimo Alvaro,
seduto al tavolo con a fian- co una colonnina tortile sulla quale
troneggia, alieno, un telefono, i televisori e le lavatrici sventrati ed
abbandonati nelle case di Laino Castello, la foto di Concia, la contadina
musa ispiratrice di Cesare Pavese, il tramonto ripreso da Cirella Vecchia.
Teti riesce a ritrarre l’anima delle persone e dei luoghi, il pave- siano
“dio incarnato nel luogo”. Persone e luoghi di cui si avverte, immedia-
tamente ed inspiegabilmente, nostalgia, una struggente nostalgia
dell’altrove rappresentato.
Continuando a camminare Teti ti racconta di quello snodo fondamentale
della psicologia collettiva, di quella rottura antropologica che si
produce quando i calabresi, di recente, sono costretti a passare da una
fatica inumana all’ozio, che, invece, fino a soli pochi decenni fa era
prerogativa esclusiva dei ricchi “rentiers” nullafacenti. Ti svela il
percorso che ha portato i calabresi a trasfor- marsi da faticatori
instancabili ad assistiti, facendo giustizia della presunta persistenza di
un ”ora locale” lenta che potrebbe, e vorrebbe, fare a meno del lavoro a
favore di un’altrettanta presunta vocazione all’otium, connaturata
nelle popolazioni meridionali e calabresi. Annuisci vivacemente quando
dice che il “locale” cui bisogna guardare è quello di oggi, non quello
inesistente del passa- to. Se nell’800 era stata l’auto-esaltazione
letteraria di alcuni valori che l’ar- retratezza portava con sé (la
fierezza mai doma, l’orgoglio, la sobrietà, ma an- che la ritrosia e
l’ombrosità) ad impedire che si formasse una salda e positiva i- dentità
culturale, sembra che ora la si voglia sostituire con l’auto-esaltazione
i- deologica della arretratezza sostenendo che essa, oltre che portare
miseria e di- soccupazione, sia in grado di veicolare, però, anche una
cultura profondamente antagonista. Una cultura ed una società fatte di
tempo meridiano, di lentezza, di vite scandite da tempi che escludono il
profitto, prefigurando, così, una so- cietà pienamente anticonsumistica e
salvifica. Vito Teti e, più modestamente, io crediamo che il bel tempo
antico sia un mondo che avrebbe dovuto cambia- re, è vero, senza i traumi
dell’emigrazione e dell’abbandono che si sono verifi- cati in tempi
recenti. Un mondo che, però, non deve essere né mitizzato, né ne- gato, ma
reinterpretato e riguadagnato alla nostra vita contemporanea come in-
dispensabile elemento identitario e di ricchezza psicologica individuale e
col- lettiva
Aggiungo che il ricordo recente delle fatiche avrebbe dovuto far
giustizia an- che delle barzellette sull’indolenza dei calabresi come le
molte raccontate, per esempio, da un comico calabrese (non sarà un
ossimoro?) che, in virtù d’alcune comparsate televisive, ha goduto quest’estate
della sponsorizzazione della Re- gione Calabria. Chi ci governa,
evidentemente, si diverte a far rappresentare i propri conterranei come
degli scansafatiche costituzionali.
Riprendendo a camminare, Vito Teti ti suggerisce la ragione profonda
dell’in- compiutezza delle migliaia di case-palazzi calabresi finite solo
per un piano o due e prive d’intonaco all’esterno. La casa, per i
calabresi, è il centro del centro del mondo che è il paese. L’interno
della casa è, innanzitutto, un luogo d’acco- glienza, introiettato come un
rifugio dopo tanta storia di precarietà e miseria mentre l’esterno è
non-finito, incompiuto perché non riguarda noi, riguarda gli altri che
sono esterni a noi, trasformando, così, la casa anche in un luogo di
esclusione. Questo rapporto interno/esterno - che non riguarda solo la
casa - rappresenta, forse, la piega più riposta della nostra anima di
calabresi, fa parte delle nostre ombre e, aggiungo io, di quell’inconscio
collettivo non rimosso che andrebbe analizzato, riportato alla luce del
conscio ed in qualche modo assor- bito, dopo averne sterilizzato la carica
negativa.
Ti commuovi quando ti parla dell’osteria nei pressi di S. Nicola da
Crissa, suo paese natale, e dell’ultima bevuta che racconta esservi
avvenuta con le persone amate della sua vita che non ci sono più. Una
forte emozione ti coglie quando Teti, nella scuola elementare abbandonata
di Laino Castello, lascia il tuo brac- cio per chinarsi a raccogliere un
quaderno fra i tanti sparsi per terra e se lo met- te in tasca, perché, ti
dice, quel quaderno a righe pieno di vocali è come una lettera d’addio ad
un luogo che si lascia per sempre e merita, quindi, di essere custodito
come un bene prezioso. Hai gli occhi lucidi mentre leggi, quasi al ter-
mine del libro, lo struggente e densissimo dialogo sulla morte che Teti
intrat- tiene con sua madre, mentre passano in treno da Cirella Vecchia,
uno dei tanti paesi morti di questa terra.
Giunto alla fine della lunga camminata ti rendi conto che avresti bisogno
an- che tu, come Teti, di un’arca per custodirvi dentro tutte le cose, le
immagini, i luoghi, le persone che ti sono venuti incontro e ti hanno
emozionato al punto che hai voglia di ricominciare il viaggio per
rivederli, per sentirli ancora. Per tua fortuna puoi farlo quando vuoi
perché la tua arca è lo straordinario libro che hai fra le mani. Ti
congedi dall’amico, ormai fraterno, con un abbraccio e con la convinzione
acquisita che solo chi ha un luogo possa andare oltre il luogo, senza un
luogo si è sempre senza luogo e sempre fuori luogo ed i calabresi sem-
brano essere sempre “in fuga” dai propri luoghi. Fuggendo finiscono per
non a- vere più un luogo, una memoria ed un senso dei luoghi, un’identità.
Credo che si debba iniziare da questo per rifondare, ab imis
fundamentis, le Calabrie. Credo che il dibattito culturale e politico
debba ripartire da queste assenze perché non vi può essere futuro senza la
certezza, memori di quello che si è stati, di quello che si è. Ora ed in
questo luogo.
dicembre 2004
|
